Valutazione del personale: intervista ad Andrea Castiello D’Antonio
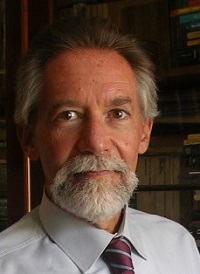
LA VALUTAZIONE DEL PERSONALE:
INTERVISTA AL PROF. ANDREA CASTIELLO D’ANTONIO
di Elisa Pedini
Una delle tante cose che amo profondamente del mio lavoro, è la grandissima opportunità che mi offre di conoscere personalità d’altissima profilatura e di profondo spessore umano.
Ovvero, eccellenze italiane che portano alto il nome del nostro Paese in tutto il mondo.
Stavolta, il lavoro di ricerca accademica nell’ambito della valutazione delle prestazioni, mi ha condotta, con somme gioia e ammirazione, a rapportarmi con figure accademiche di altissimo livello.
Dipartimento di Business and Management di Kainós® in cui insegno, questo ambito è l’hot core dell’insegnamento e della formazione.
Come sapete, Kainós® Magazine è la testata dell’Accademia, il di cui picco d’orgoglio è l’eccellenza nell’insegnamento e nell’apprendimento.
Per tale ragione, il Magazine ha sempre proposto al suo pubblico personalità italiane eccellenti, che si sono distinte a livello mondiale per risultati e spessore umano.
Per conseguenza, anche questa volta, voglio condividere con voi l’onore che ho avuto io d’approcciarmi a due grandi menti italiane.
Come sempre, lascerò parlare direttamente loro attraverso due interviste: la Prof.ssa Laura Borgogni e il Prof. Andrea Castiello D’Antonio.
Parto con il Prof. Andrea Castiello D’Antonio, romano e nella Capitale ha mantenuto il suo headquarter e svolge la sua attività da quarant’anni.
Specializzato in psicologia, psicoterapia, psicologia clinica e psicologia del lavoro e delle organizzazioni.
Considerato un luminare accademico del panorama italiano, è attivo sia nel campo della ricerca, che all’interno delle organizzazioni per quanto concerne lo sviluppo delle risorse umane.
Membro delle più autorevoli associazioni americane e anglosassoni e autore di numerosa, pregevole, letteratura, tra cui “Il colloquio di valutazione delle prestazioni”, “Zulliger Test”, “Come, quando e perché la formazione non funziona” e “La selezione psicologica delle risorse umane” che ho personalmente letto e utilizzato.
Non mi dilungo oltre e lascio ad Andrea la parola.
D: Nelle organizzazioni la metodologia più classica e consolidata per la valutazione del personale sembrerebbe quella cosiddetta delle tre P: posizione, prestazione, potenziale. Che cosa ne pensi?
ACD: «Il Modello delle tre P è quello tradizionale, ormai entrato nell’uso comune dell’azienda.
Esattamente, parte dall’analisi dei ruoli e delle posizioni di lavoro per proseguire con l’analisi e la valutazione delle prestazioni e, infine, guardare al futuro. La terza P è quella relativa al potenziale ed è sicuramente la parte più interessante.
Per quanto riguarda la prima P, ovvero la posizione, bisogna dire che oggi, il concetto di posizioni organizzative è cambiato molto, perché sono diventate molto fluide, cambiano continuamente, quindi, piuttosto si preferisce parlare di fasce o aree professionali.
Ad esempio, oggi, è facile che una persona si trovi a fare il Project Manager in un progetto e contemporaneamente essere un Program Manager in un altro, quindi con responsabilità e compiti ben più elevati.
La Pubblica Amministrazione in questo senso funziona in modo molto diverso.
Qui, le persone vengono inserite nelle cosiddette “piante organiche” e in caselle, le tradizionali posizioni di lavoro.
Tutto è chiaramente esplicitato: compiti, responsabilità e confini di ruolo. In altri termini, si viene inseriti in uno spazio-tempo definito (la posizione) che ha in se stessa i contenuti specifici del processo di lavoro.
Comunque, laddove esistano organigrammi molto complessi, ha un senso parlare di posizioni.
Il passo successivo, la seconda P, è relativa alla prestazione, cioè al valutare cosa una persona fa all’interno del proprio spazio organizzativo.
Trattasi d’una valutazione che si compie all’interno del delicato rapporto capo-collaboratore.
Generalmente, tale valutazione si compie una volta l’anno, ma recentemente questa usanza si mostra alquanto riduttiva e i tempi possono essere assai più ridotti.
In verità, dovrebbe svolgersi sulla base di un colloquio collaborativo, vissuto in un clima di agio sociale.
Tuttavia, nelle situazioni organizzative di pressing sui tempi svolgere un colloquio completo, profondo, che prenda i suoi tempi non è quasi mai possibile.
Di fatto, si tratta di un colloquio in cui valutare comportamenti e obiettivi inerenti la performance del collaboratore con la prospettiva d’uscire con una “diagnosi” sul passato, un punto della situazione attuale e una pianificazione delle azioni per il futuro.
In realtà, è un’attività abbastanza semplice, ma, di fatto, si inseriscono una serie di problematiche e di eventi che la complicano incredibilmente.
In particolare, il valutatore può essere tratto in inganno dai propri pregiudizi, da aspettative non dichiarate, o dalla relativa mancanza di osservazioni svolte nel corso del tempo sulle modalità con cui il collaboratore ha operato.
Ma, può anche essere indotto a trattare il collaboratore in modo molto generoso, finalizzato al mantenimento del quieto vivere.
Soprattutto, laddove ci sia la consapevolezza – da parte del capo – d’aver richiesto un gran numero di attività in via informale.
A tal riguardo, infatti, chi valuta tende a dare un grande peso al fattore della disponibilità del collaboratore.
In conclusione, ciò che dovrebbe essere un percorso oggettivo e sereno, si complica in modo esponenziale per una serie di fattori inconsapevoli e consapevoli.
La terza P, è quella relativa al potenziale di cui la persona è portatrice.
Tutti hanno un gradiente di potenzialità di sviluppo e quindi, si tratta di individuare e poi, sviluppare, tale qualità soggettiva.
Fino a poco tempo fa, la visione era molto limitata e si riteneva che oltre un certo limite di età- talvolta assai basso, intorno ai trent’anni – non valesse la pena valutare il potenziale.
Da qualche tempo, per fortuna, le cose sono cambiate e si è ben compreso che anche un cinquantenne possa avere un proprio potenziale su cui investire.
La valutazione del potenziale è senza dubbio un’attività difficile perché previsionale.
Di fatto, è una scommessa sullo sviluppo delle competenze trasversali.
Certo, qui si pone il problema delle metodologie; e sono diverse e differenziate le metodologie per valutare il potenziale di sviluppo.
Comunque, tutte caratterizzate da una notevole complessità.
Il momento conclusivo del processo di assessment del potenziale è costituito dal feedback, un momento che rappresenta un aspetto importante perché consente al soggetto valutato di sviluppare consapevolezza su di sé e l’autoapprendimento.
Questi sono punti focali dello sviluppo della persona.
Lo scopo dev’essere quello di ampliare attività e responsabilità non solo in senso verticale, ma anche orizzontale.
Infatti, motivare dando più denaro, è facile; ma il vero valore del capo è riuscire a dare motivazione facendo leva sui parametri non monetari, qualcosa che vada oltre il tipico scambio contrattuale, prestazione-remunerazione, che naturalmente deve esserci sempre ma costituisce solo la base del rapporto di lavoro».
D: Focalizzandoci sul panorama italiano, secondo la tua profonda esperienza, tanto in ambito accademico quanto organizzativo, potresti fornircene una fotografia aggiornata?
ACD: «Secondo la visione che ho io del panorama italiano, dividerei la situazione attuale in tre blocchi.
Il primo, costituito dai grandi gruppi e dalle multinazionali.
Qui, questi sistemi di valutazione agiscono in modo naturale. I sistemi di gestione e sviluppo del personale sono impiantati in modo molto evoluto, anche a livello tecnologico, e inquadrati nel contesto delle attività di gestione e sviluppo del capitale umano.
Il secondo blocco è costituito dalle aziende di fascia intermedia, dove molto dipende da quanto l’AD, il direttore generale o l’imprenditore siano illuminati.
Purtroppo, alcuni sono rimasti ancorati alla visione del personale come un mero mezzo per raggiungere l’obiettivo aziendale e nulla più.
Il terzo gruppo, è il sostrato della piccola-media imprenditoria, importantissimo; ma molto focalizzato sull’aspetto tecnico.
In tale ambito, per la gestione del personale molto spesso ci si appoggia ad agenzie esterne, più o meno specializzate nel comparto della gestione e sviluppo del personale, oppure addirittura agli studi di consulenza del lavoro».
D: Nell’ambito della ricerca accademica sulla psicologia del lavoro ti sei occupato e hai scritto di molti temi sviscerandone i punti cardine. Potresti parlarci di qualche studio che stai conducendo ora?
ACD: «Occupandomi di questa attività da oltre quarant’anni, ho potuto notare come alcuni temi ritornino piuttosto costanti e invece, come altri siano contestualizzati al momento e agli eventi.
Un tema ricorrente su cui ho impegnato e impegno molto del mio lavoro di ricerca è la gestione dei conflitti tra individui, all’interno del team e tra squadre, ovvero, come gestiamo la nostra aggressività e quella altrui.
Su questo ho recentemente pubblicato Conflitti, un libro scritto a quattro mani con Luciana d’Ambrosio Marri, sociologa del lavoro.
Qui, mettiamo a fuoco anche i conflitti nella vita di lavoro e affinate metodologie per prevenire o gestire le divergenze anche intense in modo costruttivo, compreso il come affrontare l’aggressività e le emozioni sottostanti il disagio del conflitto.
Un altro campo di ricerca più recente è centrato sulle relazioni tra il livello di potenzialità e le possibilità di formazione.
Infatti, gli interventi di formazione manageriale sembrano avere efficacia quasi esclusivamente su soggetti che possiedono un potenziale medio-alto.
Al contrario, su persone che hanno scarso potenziale e limitata motivazione, tali interventi non mostrano un vero e proprio potere evolutivo.
Qui, si apre l’interrogativo per le aziende su quale investimento fare, su quali risorse e puntando su quali obiettivi.
Ovviamente, esistono metodologie più mirate ed efficaci rispetto ad altre».
D: Uno dei tuoi recenti studi che trovo molto interessante e che secondo me, va messo in luce e portato all’attenzione dei nostri lettori riguarda un ambito molto importante: la psicopatologia della leadership. Gli impatti di questa problematica sono piuttosto lapalissiani. Ce ne puoi parlare?
ACD: «Sì, certo.
Purtroppo, abbiamo molti esempi di questo tipo di disfunzione organizzativa e di pseudo-capi che dirigono imprese private o amministrazioni pubbliche.
Ho iniziato ad occuparmene negli anni ottanta, partendo da osservazioni effettuate sul campo e in presa diretta.
Nel senso che, nel giro di qualche tempo, ho iniziato a rendermi conto della diffusione inquietante di patologie personali nei manager e nei capi in senso generale, e di quanto tali squilibri si potessero ripercuotere sulle persone gestite.
Di fatto, su questo tema in particolare, dapprima ho visto all’opera nel concreto della vita di lavoro soggetti “malati”.
Successivamente ho preso contatto con la letteratura (a quei tempi assai limitata) in cui si rifletteva sulle “malattie del potere”, sulle “nevrosi organizzative” e simili.
Nel 2001, dall’insieme delle mie osservazioni e di ciò che andavo studiando, decisi di pubblicare le conclusioni di tali studi.
Più recentemente ho pubblicato L’assessment delle qualità manageriali e della leadership. La valutazione psicologica delle competenze nei ruoli di responsabilità organizzativa, in cui riprendo e amplio le considerazioni teoriche e di metodo elaborate allora.
Oggi, anche in Italia, per fortuna, si comincia a parlare di psicopatologia della leadership, non solo negli ambiti aziendali classici ma anche nell’ambito delle Forze Armate.
Qui, sottolineo che negli USA le analisi sulla patologia della leadership militare risalgono a un decennio fa».
D: Quali sono gli altri ambiti della leadership su cui stai lavorando?
ACD: «Molti, ma sicuramente mi piace citarne due perché sono molto attuali e mi impegnano sia sul versante professionale sia su quello della ricerca.
Il primo è il Global Team.
Vale a dire, la gestione dei gruppi di lavoro decentrati in diverse località nel mondo, un argomento che occupa un posto di rilievo per l’impresa multinazionale che agisce worldwide in una realtà multietnica.
Rientriamo in una casistica ormai piuttosto diffusa: tipico è il caso in cui il manager, ad esempio un Program Manager, risiede in Italia, ma il suo team è disperso per il mondo, con nuclei operativi in Europa e oltreoceano.
Per conseguenza, il manager deve gestire senza avere il controllo diretto sui suoi collaboratori, molti dei quali, magari, temporanei.
Inoltre, sono persone che il più delle volte non vede mai fisicamente e con le quali ha soltanto scambi per mezzo della tecnologia. Quando va bene anche in videoconferenza, ma spesso quasi soltanto via email.
In queste situazioni è necessario focalizzarsi sul grado di fiducia e commitment che il manager riesce a creare con il suo team.
Su questa tematica è recentemente uscita in italiano la traduzione di un importante testo di Jo Owen, Il manager globale. Come raggiungere prestazioni elevate.
Il secondo argomento di ricerca e di lavoro, è l’auto-percezione, ovvero la percezione di sé da parte del collaboratore.
Esattamente, la maggior parte delle informazioni che noi abbiamo su come è vissuto il mondo del lavoro sono prodotte dai livelli intermedi e apicali e, da lì, per così dire, si guarda verso il basso della piramide.
In questo caso, l’attenzione è centrata sui collaboratori, una impostazione denominata Followercentric approach to leadership.
Si tratta di un punto di vista molto importante perché offre l’opportunità di rivedere la gestione della leadership partendo da come il collaboratore vede se stesso e la sua relazione con il management».
La valutazione del personale:
– Intervista alla Prof.ssa Laura Borgogni