PILLOLE DI: Eugenio Montale
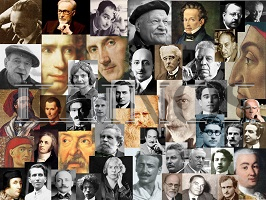
PILLOLE DI:
LETTERATURA ITALIANA
EUGENIO MONTALE
LA POESIA QUALE TESTIMONIANZA DELLA CONDIZIONE ESISTENZIALE DELL’UOMO
NON CHIEDERE AL POETA E ALLA POESIA LA PAROLA CHE «SQUADRI»
PERCHÉ POSSONO SOLO DIRTI COSA NON È L’UOMO, COSA NON VUOLE
L’UOMO NON PUÒ CHE PROVARE IL MALESSERE DI VIVERE SEPARATO DAL MONDO
di Elisa Pedini
Eugenio Montale rappresenta una delle figure di spicco del Novecento, tanto italiano quanto europeo. Personaggio geniale, ma per comprendere appieno la sua opera, dobbiamo prima capire l’uomo e il suo pensiero.
Quindi, come sempre, partiamo da lui: Eugenio.
Innanzi tutto, egli nasce a Genova, città bella e curata di mercanti, imprenditori e commercianti che conosce una parabola ascendente di prosperità e sviluppo in quel periodo che va sotto il nome di Belle Époque.
Nonostante la sua vita sia stata piuttosto lunga, Eugenio ha una salute fragilina e malaticcia che gli preclude, apparentemente, alcune possibilità.
Infatti, la sua famiglia, imprenditori appartenenti alla florida borghesia genovese, lo mandano a studiare dai Barnabiti e proprio confrontandosi sulla salute del figlio col Rettore, tal Padre Trabattoni, decidono di fargli intraprendere studi tecnici, più brevi e al dunque meno impegnativi per l’intelligenza viva di Eugenio.
Tuttavia, l’amore per gli studi letterari si fa strada in lui molto precocemente e li persegue privatamente, con passione, costanza e determinazione, contestualmente agli studi tecnici, che completa con buoni risultati.
S’appassiona follemente di Dante, Petrarca e Boccaccio.
Ancora una volta, è un autodidatta a diventare un genio acclamato.
Mi piace qui sottolineare che la sorella Marianna, di costituzione meno sfigata, intraprende al contrario gli studi classici per procedere con quelli umanistici, seppur sceglierà di non discutere mai la tesi. Purtroppo, non avrà vita lunga come il fratello minore. Beffarda è la vita. Lui, sempre malaticcio, vivrà fino a 85 anni. Lei, verrà stroncata da una malattia a soli 44 anni.
Tuttavia, entrambi introversi, sviluppano una forte intesa intellettuale, che influenzerà molto Eugenio.
Inoltre, sarà proprio Marianna la prima “lettrice privata” e sostenitrice delle prime poesie del fratello.
Ora, per quanto poco si sappia della vita privata della famiglia Montale, tuttavia, sappiamo che è di stampo imprenditoriale e pragmatico. Da cui, si potrebbe supporre un interesse più volto agli studi economici o scientifici dei figli piuttosto che letterari.
Al contrario, così non è.
Pur storcendo un po’ il naso, la famiglia non frena gli interessi e gli studi dei due figli minori.
Dunque, si può supporre: per un verso, una mentalità abbastanza aperta e per l’altro, influenze importanti nelle frequentazioni familiari: come quella di tal Padre Semeria, oratore, scrittore, personaggio pubblico molto in vista e molto influente del primo decennio del 1900, nonché vicerettore dell’Istituto dei Barnabiti, nonché insegnante privato di Marianna e non da meno quella di Padre Trinchero, seguace del modernismo di Semeria e caro, intimo amico di famiglia.
A far da sfondo la gente e la terra di Liguria. La fervida Genova in primis e in secundis, la Riviera di Levante, dove la famiglia trascorre le vacanze.
Di fatto, Eugenio Montale, fanciullo, forma così la sua personalità: molto colto, libero di pensiero, introverso. Avrebbe voluto essere «scabro ed essenziale» come i «ciottoli (…) mangiati dalla salsedine» della sua terra; ma è proprio dall’osservazione che egli diviene, invece, pensatore profondo, osservatore minuzioso, critico attento, o per dirla col Montale stesso: «uomo attento che riguarda» per «cercare il male che tarla il mondo». (Ctz. da Montale E., Avrei voluto sentirmi scabro ed essenziale, in Ossi di Seppia, Piero Goberti Editore, Torino, 1925)
Contro ogni aspettativa, nel 1917, viene ritenuto idoneo all’arruolamento e spedito in fanteria. È proprio durante la guerra che conosce Sergio Solmi, appena diciottenne, ma destinato a divenire una voce molto influente del ‘900 proprio come Eugenio Montale. Secondo “lettore privato” dei componimenti d’Eugenio. Così, la letteratura li unisce e cementa un’amicizia che durerà tutta la vita. L’uno sarà geniale poeta, l’altro acuto critico letterario.
Di fatto, nel 1920, Eugenio viene congedato e ha già molto chiara davanti a sé la sua strada di poeta.
S’innamora follemente di Joyce e di Italo Svevo, che sosterrà senza remore.
Nel 1925, pubblica la sua prima raccolta: Ossi di seppia.
Qui, la sua posizione nei confronti della poesia del suo tempo e la sua poetica si delineano in modo netto e chiarissimo.
In particolare, cito Non chiederci la parola, che apre il gruppo da cui prende il titolo l’intera raccolta. Poesia in tre quartine, composte di versi vari nella misura e nelle rime.
Ben ci sottolinea Riccardo Marchese che essa «(…) possiede la concisione e il rigore di una dichiarazione di “arte poetica” ed è nello stesso tempo una definizione esistenziale non solo dell’animo del poeta, ma di un’intera generazione.» (Ctz. Marchese R., Panorama, La Nuova Italia, 1966, pg. 63)
Infatti, già evidente nel titolo siamo di fronte alla poesia della negazione.
Esattamente, Eugenio Montale dialoga coi suoi lettori rispondendo a una domanda più o meno esplicita del suo pubblico che chiede «(…) la parola che squadri (…) a lettere di fuoco (…)», ovvero, quella che dichiari, definisca, risplenda netta.
Ma, non ci sono più certezze, l’Europa è in subbuglio, la vita è in subbuglio, «(…) l’animo nostro informe (…) in mezzo a un polveroso prato (la vita, n.d.r.).».
Così, la parola che definisce, «la formula» non appartengono più all’intellettuale. La scelta lessicale accurata rievoca costantemente immagini di aridità, rovina, arsura e la realtà della povertà e mediocrità della vita si fa duro impedimento, «scalcinato muro», ove l’anima, il mondo interiore si stampa come un’ombra.
A tombale chiarimento della posizione montaliana, la poesia chiude con la peggiore e più impietosa definizione che si possa dare di qualcosa: ovvero, dicendo ciò che non è.
«Codesto solo oggi possiamo dirti,
ciò che non siamo, ciò che non vogliamo.»
Il distanziamento è totale.
Il distacco da ciò che è, è abissale.
Infine, un’altra tematica cara al poeta è la poesia della memoria.
Per Montale, la memoria è la chiara percezione che neppure essa ci appartenga: ovvero, la percezione della nostra terribile leggerezza.
A tal riguardo, mi piace citare: Cigola la carrucola del pozzo. Poesia composta da endecasillabi liberamente rimati.
Ho scelto questa poesia poiché essa si basa su di una analogia, che non è tra le figure retoriche predilette da Montale.
In più, il secchio è l’oggetto fisico da cui prende vita e si dipana la poesia. La pesantezza del secchio compensa il vuoto del cerchio del pozzo, ovvero il nulla che schopenhauerianamente risiede dietro alla rappresentazione fisica, al mondo.
Così, il secchio fa pensare a un volto che riaffiora nella nostra memoria. Ma, come quando si guarda qualcosa attraverso l’acqua essa si deforma, così avviene al ricordo, perché noi non abbiamo coscienza del passato. Si tratta d’un riaffiorare momentaneo nel presente, ma come torna il processo razionale, tutto risprofonda nel passato così come il secchio torna giù nel pozzo.
Di nuovo, la senzazione di distacco è totale.
Mi piace sottolineare quanto T.S.Eliot, in un suo articolo del 1919, dice relativamente al correlativo oggettivo. Concetto che Eugenio Montale, conoscitore ed estimatore di Eliot, fa suo.
Infatti, l’oggetto in Montale perde la sua fisicità per farsi simbolo della condizione esistenziale e portatore della tematica della poesia, cercando al comtempo di fornire una sorta di risposta attraverso l’evocazione d’una precisa e potente emozione.
Ricordiamo che siamo già nel periodo fascista e l’atteggiamento di Montale è quello di prendere immediate quanto abissali distanze dal regime, anche a costo d’una morte civile. Infatti, firma senza indugi il manifesto anti-fascista di Benedetto Croce.
Tuttavia, attenzione, la posizione intellettuale di Eugenio era già chiara sin da fanciullo. Lo abbiamo già scritto.
Infatti, il suo essere “anti-*”, il suo essere “contro”, non è politico; ma intellettuale, culturale, snobistico se vogliamo. La sua è una posizione radicale e interiore.
Alla mancanza d’intelletto d’un regime, egli oppone l’assenza dell’intellettuale.
In tal senso, Eugenio Montale si fa portavoce degli intellettuali dell’assenza.
Invero, come spesso accade, la posizione nella teoria, non è così ben definita nella prartica perché inevitabilmente, l’intellettule si fa antenna ricettiva del suo tempo e ne recepisce gli influssi e le contaminazioni. Così sarà per la figura pubblica di Montale, quanto per la sua poesia.
Infatti, l’intelligentia italiana riconosce, da subito e da sempre, a questo poeta una statura notevole, nonché una cultura veicolante per l’intero panorama culturale europeo.
Altresì, oltre al suo ruolo di cultore della poesia, egli si fa intellettuale guida, che veicola idee, commenta e critica certe situazioni.
Per Montale, il ruolo d’intellettuale pubblico è molto importante e potente.
A differenza, per esempio, d’un Ungaretti, che scansa e rifugge il ruolo di Maestro perché troppo impegnato a essere, primariamente, un uomo.
Eugenio prende le distanze dal fascismo, perché il pensiero è libero e tale è l’intellettuale.
Prende le distanze dalle avanguardie perché non ne condivide le idee distruttive, né le loro scelte lessicali. Così come s’allontana dai parnassiani, ma altrettanto dai rondisti.
Mette distanza tra sé e i pascoliani e i dannunziani.
Allora, qual è la posizione di Eugenio Montale?
Essa s’approssima, ma non tange quella crociana.
Egli per la poesia si riallaccia alla più bella tradizione poetica italiana: il Petrarca, il Dolce Stil Novo, Giacomo Leopardi, perché, per lui, la poesia deve avere il contatto con l’Assoluto.
Ma, andiamo a vedere come nella pratica tutto questo si traduce.
Ad esempio, il riprendere il primo verso quale titolo del componimento si riallaccia a tutta una tradizione poetica, da Petrarca in poi, di una poesia senza titolo.
Inoltre, il male e il soffrire senza ragione, che la vita stessa porta con sé e dinanzi al quale l’uomo è impotente, ci riporta a quel nichilismo leopardiano che vede la vita come dolore e la Natura come «matrigna».
Però, attenzione, perché il pessimismo montaliano, vuoi per una forte influenza del concetto del velo di Maya di Schopenhauer e la percezione del nulla dietro alla rappresentazione fisica del mondo e della vita, come accennato poc’anzi, compie un’evoluzione che è una sorta di pessimismo antileopardiano.
Mi spiego. Leopardi muove da una concezione di pessimismo storico per arrivare a un pessimismo cosmico che diviene, per lui, una certezza.
Invece, Montale inizia con un pessimismo cosmico, che troviamo tanto in Ossi di seppia quanto ne’ Le occasioni (1939). La vita è male di vivere, tutto ciò che vive soffre e dietro alla sofferenza s’accampa il nulla. Evvai!
Nel ’40 abbiamo La bufera (1943) dove il pessimismo è già storico.
Ma, dagli anni ’50/ ’60 in poi, le esperienze montaliane cambiano indirizzo ed è un Montale completamente diverso. È il periodo di Satura e l’ultimo ventennio montaliano.
Infatti, al poeta appare sempre più chiaramente che la società, la sua corruzione, le ideologie assurde sono tutti frutti marci della Storia. L’intellettuale riflette sul mondo e sulla Storia. Il pessimismo si radica nella Storia e il mondo ne esce come una sorta di schifo totale.
È il 1975, quando l’intelligentia mondiale lo riconosce quale maestro e gli tributa il premio Nobel® per la letteratura. Durante il discorso tenuto in tale sede, Eugenio Montale ripercorre la sua carriera come una scelta fatta per ragionare e svelare l’essere della poesia e la sua possibilità di vita, concludendo con la denuncia della sentenza di morte della poesia stessa.